| Novità - Eventi di rilievo |
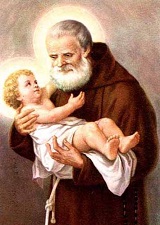 Un gruppo di frati cappuccini lombardi ha voluto celebrare a Roma il giubileo per il III centenario della canonizzazione del primo santo dell’Ordine. Fra Carlo Calloni OFM Cap, Postulatore Generale, ha tenuto una relazione sull’ambiente storico di san Felice. Avvicinandosi la sua festa liturgica (18 maggio) proponiamo questa relazione.
Un gruppo di frati cappuccini lombardi ha voluto celebrare a Roma il giubileo per il III centenario della canonizzazione del primo santo dell’Ordine. Fra Carlo Calloni OFM Cap, Postulatore Generale, ha tenuto una relazione sull’ambiente storico di san Felice. Avvicinandosi la sua festa liturgica (18 maggio) proponiamo questa relazione.
Roma – Via Veneto - 6 maggio 2013
Premessa Storica. Quadro generale
L’occasione di questa Conferenza è offerta dal vostro pellegrinaggio in occasione del terzo centenario della canonizzazione di San Felice da Cantalice, avvenuta il 22 maggio 1712 per decisione di Clemente XIV[1].
San Felice da Cantalice è il primo santo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, riforma riconosciuta ufficialmente da Clemente VII il 3 luglio 1528 con la Bolla Religionis Zelus all’indomani del Sacco di Roma del 1527 inflitto alla città eterna ad opera dei lanzichenecchi dell’imperatore Carlo V che aveva vinto i francesi e i suoi alleati (tra cui il papato) a Pavia facendo prigioniero lo stesso Francesco I.
La riforma cappuccina trova, come per tante altre realtà ecclesiali, il suo momento di passaggio, di cesura, nella celebrazione del Concilio di Trento convocato da papa Paolo III in una città imperale, ma non in territorio tedesco come chiedevano i “seguaci politici di Lutero” dopo alcuni tentativi e fallimenti avvenuti tra il 2 novembre 1542 e il 6 luglio 1543, ma di fatto convocato con la bolla Laetare Jerusalem per il marzo 1545. Apertura di fatto rinviata a causa della logorante guerra tra Francia e Impero al 13 dicembre 1545, II domenica di Avvento.
Solamente dopo la pace di Crepy, 18 settembre 1544, fu possibile convocare il Concilio, da molti richiesto per una riforma della Chiesa già a partire dal 1518, cioè subito dopo la chiusura del Concilio Lateranense V (1512-1517), convocazione che causa di varie contrapposizioni ed eventi non era stato possibile attuare. Dal punto di vista politico Carlo V conquistava la Lombardia, la Francia riceveva il Piemonte.
Fra questi Lutero e la pubblicazione , il 31 ottobre 1517, delle 99 tesi di Wittemberg, contestazione anche alla predicazione dell’indulgenza per la raccolta di fondi per la costruzione di San Pietro a Roma ad opera del domenicano fr. Joahnn Tetzel. “Quando la monetina fa pling nella cassettina, l’anima fa spling e va in Paradiso!”.
Ma anche le difficoltà nei rapporti con la chiesa “gallicana” dopo il concordato del 1516 o le stesse battaglie all’interno dell’Ordine francescano che la Bolla Ite vos in vineam meam di Leone X, 29 maggio 1517, non avevano placato.
Inoltre e non di secondaria importanza, la presenza turca nel Mediterraneo, limitava alle navi pontificie di circolare liberamente, ma allo stesso tempo si impediva da parte del papato l’intervento di Carlo V sulle coste italiane temendo un potere troppo forte sia al nord che al sud dell’Italia. Rodi cadeva nella mani del Sultano nel 1522.
Il debole e breve pontificato di Adriano VI (1522-1523), precettore e uomo di fiducia di Carlo V, uomo giusto per la riforma, ma nel momento sbagliato, era stato rallentato nei suoi interventi riformatori. La causa può essere ricercata certamente nella resistenza di molti cardinali di curia, ma anche da alcune sue manifestazioni anti-artistiche. La stessa volta della Cappella Sistina rischiò di andare distrutta.
Il suo successore Clemente VII (1523-1534), astuto e diplomatico, con una politica esageratamente filo francese aveva portato alla lega di Cognac (1526) e conseguentemente al sacco di Roma l’anno successivo, 1527. L’idea di fondo era il timore verso il “potente” Carlo V sul cui regno non tramontava mai il sole e sulla sua idea di Chiesa imperale. Dagli Asburgo aveva ricevuto i possedimenti famigliari dell’Austria e delle zone limitrofe, da parte di madre il regno di Spagna e il “nuovo mondo”, quello delle Indie Occidentali o Americhe.
Paolo III (1534-1549), Alessandro Farnese, fu l’uomo del Concilio. Conclusa la sua vita di marito[2], ordinato prete e poi vescovo nel 1519, Alessandro Farnese era già cardinale dal 1493, partecipò attivamente alla riforma della sua diocesi, Parma. Il breve conclave del 1534 lo vide eletto papa con il nome di Paolo III. Fu il motore della riforma a partire dal collegio cardinalizio, promuovendo uomini di valore: Pole, Contarini, Morone, Fischer. Approvò la Compagna di Gesù, e istituì l’Inquisizione, 1542. Nepotista non riuscì a riformare la Curia romana e neppure la residenza dei Vescovi nelle proprie diocesi[3].
Felice Porri da Cantalice chiede ai cappuccini di Cittaducale, tra il settembre e l’ottobre del 1543, di entrare in religione.
Dalla biografia scritta da Mattia Bellintani da Salò, scoperta poco tempo da fr. Vincenzo Criscuolo tra i documenti “dimenticati” dell’Archivio della Congregazione per la Cause de Santi e pubblicata nel 2012, così scrive “egi era allora di età di circa trent’anni, perch’egli dir soleva che al sacco di Roma era di età di dodici anni, e del 1543 ei venne alla religione. Et al primo se ne andò al luoco de’ frati capuccini di Civita Ducale, e trovato il guardiano, semplicemente gli scoprì il desiderio suo, et humilimente chieseli di essere accettato nella religione. Il guardiano faceli ben’intendere la maniera del viver capucino rigida e molto dura………..Onde menatolo in chiesa e mostratogli un crocifisso tutto insanguinato e livido, dicendogli. Vedi giovine, quanto ha patito Christo per noi……………….”.
Mandato a Roma al convento di Monte Cavallo sotto il Quirinale per essere accettato formalmente in religione dal Vicario provinciale (fr. Raffaele da Volterra). Guardiano della fraternità di Roma Monte Cavallo era fr. Bernardino Palli d’Asti, già Vicario generale dell’Ordine. Accolto fu inviato ad Anticoli, l’antica Fiuggi, dove passò l’anno di noviziato, 1543-1544. Da lì, prima della professione religiosa soggiornò a Monte San Giovanni Campano e fatta la professione l’obbedienza lo portò a Tivoli e poi Viterbo e dal 1547, a Roma, dove rimase fino alla morte avvenuta il 18 maggio 1587. Era il lunedì d Pentecoste e i Cappuccini stavano celebrando il loro XX Capitolo generale.
Il periodo posto alla nostra attenzione sono i 44 anni della “vita di religione del nostro Santo”, beatificato da Urbano VIII, Maffeo Barberini, il 1 ottobre 1625 e canonizzato. Come ho già ricordato, il 22 maggio del 1712 da Clemente XI (Giovanni Francesco Albani).
Vita della riforma Cappuccina
Come e cosa vive la neonata riforma francescana in questi anni?
E che riflessi hanno sulla vita del santo frate questuante Felice?
Quando Felice sta decidendo ad entrare tra i cappuccini, Paolo III, il 22 maggio 1542, ritentava la convocazione del Concilio, questa volta non più a Mantova-Vicenza, ma a Trento, per il 1 novembre 1542, mentre la riforma cappuccina si apprestava a vivere il suo secondo drammatico momento che nei primi vent’anni di vita l’avevano investita. Il primo di questi momenti era stato il doppio Capitolo del 1535/1536 e l’abbandono forzato dei fratelli Tenaglia, Ludovico e Raffaele da Fossombrone. Fr. Matteo da Bascio aveva lasciato la riforma già da tempo continuando quel vivere di predicatore itinerante che lo portò alla battaglia di Mühlberg[4]
Il 22 agosto 1542, Bernardino Tomassini da Siena detto l’Ochino, Vicario generale della nata riforma cappuccina, era in fuga attraverso la Valtellina per raggiungere i Grigioni. Superato il confine il 31 agosto 1542, raggiungeva Ginevra ricevuto con calore da Calvino.
Il fatto, che di per sé potrebbe avere tutta la coloritura di una crisi personale[5], ha riflessi su tutta la riforma cappuccina, sia nella sua vita interna sia in quella esterna.
Le modificazioni intervenute nella conduzione quotidiana della comunità indicano un cambiamento di più ampia portata, ponendo fine a quel periodo che Bernardino Cioli da Colpetrazzo ha definito come «il più glorioso appresso al mondo» [6].
La predicazione dell’Ochino costituiva un vanto per tutto l’Ordine che, oltre ad essere conosciuto e apprezzato in tutta l’Italia, veniva allo stesso tempo invidiato per avere in lui una «tromba così chiara e sonora»[7] incentrata sull’Amore di Cristo Crocifisso. Fr. Bernardino Tomassini illuminava e riscaldava non solo il cuore dei secolari, ma attirava l’ammirazione dei giovani frati, rompendo quel faticoso equilibrio raggiunto dal suo predecessore nella carica di Vicario dei Cappuccini, Bernardino Palli d’Asti, che aveva dovuto ricucire lo strappo traumatico operato da Ludovico Tenaglia da Fossombrone e dal doppio Capitolo del 1535-1536. La prima grande tensione che la nata riforma cappuccina aveva dovuto affrontare.
Le Costituzioni del 1536, uscite dal doppio Capitolo, sono il punto di partenza per comprendere le differenti mentalità che si sono formate e realizzate nei primi cinquant’anni di vita della riforma cappuccina, generando, così come li descrivono i primi cronisti dell’Ordine, gli stati della riforma che con sé inevitabilmente portavano le differenti generazioni di frati.
Due le considerazioni per quel primo periodo “preconciliare”.
In primo luogo, sarebbe troppo ingenuo considerare questi mutamenti nell’ambito delle ambizioni personali o delle differenti modalità di interpretare la Regola e il Testamento. Nelle Cronache, nelle Historie, e nella Legislazione si fissa un modo di vivere quotidiano, concreto, non teorico; ci sono cristiani e frati reali che con passione ricercano il modo di vivere più attuale per concretizzare la spiritualità di Francesco d’Assisi, per non rendere ideologico il loro vivere.
In seconda battuta, non è neppure una questione di numeri “neutri”, variabile da non nascondere, ma neppure da mitizzare. Dai “pochi” che compongono la legislazione di Albacina ai “molti” che devono trovare un accordo a Roma nel 1536. I numeri contano, ma conta anche la composizione del gruppo, la loro estrazione.
I primi frati cappuccini, almeno fino al 1545, provengono tutti dall’Osservanza, con una tensione per vivere integralmente la Regola. Uomini temprati da una lotta interna al francescanesimo. Lotta che aveva trovato uno sbocco nella Ite vos in vineam meam di Leone X emanata il 29 maggio 1517, ma che non aveva arrestato il movimento profondo di riforma.
Chi era allora il frate cappuccino?
Quello della prima generazione che aveva redatto le prime Ordinazioni di Albacina nell’aprile del 1529 presso l’eremo di santa Maria dell’Acquarella, guidati da Ludovico Tenaglia da Fossombrone[8]? O quello che Bernardino Palli d’Asti fa emerge dalle Costituzioni del 1536? O ancora quello che incarna Bernardino Tomassini da Siena? O quello del Commissario papale Francesco Ripanti da Jesi? O quello che sarà canonizzato in Felice da Cantalice?
Ludovico Tenaglia da Fossombrone si era unito al personale ed isolato movimento di Matteo Serafini da Bascio che con «habitello stretto e cappuccio aguzzo, scalzo, con una croce in mano», si dedicava alla predicazione itinerante e solitaria, reclamando la possibilità di osservare la Regola alla lettera.
Erano questi la generazione che, fuggita dall’Osservanza, si sentiva libera di poter incarnare e vivere sine glossa tutto il cuore del francescanesimo, Regola e Testamento, in un clima di eremitica fraternità. Era la medesima generazione che il 3 luglio 1528 aveva ottenuto la bolla Religionis Zelus, che permetteva ai fratelli Tenaglia, Ludovico e Raffaele, di condurre vita eremitica e di osservare la Regola di Francesco d’Assisi «quanto lo consente l’umana fragilità», di portare la barba ed un abito con il cappuccio quadrato, di poter predicare al popolo e di poter ricevere novizi[9]. Gli effetti dell’approvazione pontificia non tardarono a manifestarsi facendo accorrere altri osservanti che volevano vivere allo stesso modo dei due fratelli destinatari della bolla.
Diversi sono dunque i fattori che segnano in maniera significativa il gruppo della nuova riforma. Innanzitutto sono pochi; all’inizio del 1529 si contano una trentina di frati dislocati in quattro eremi[10], provengono tutti dall’Osservanza, dove hanno ricevuto la loro formazione, e aspirano alla totale imitazione della forma vitae di san Francesco e dei primi compagni[11]. Il desiderio di vivere in romitori è la costante, esigenza insostituibile: non solamente presero luoghi lontani […] ma furono molti che con licenza de’ superiori nel proprio sito del luogo si facevano celluzze, ove abitavano per starsene più riturati, digiunando di continuo in pane ed acqua, per darsi più perfettamente alla santa contemplazione[12].
A solo un anno di distanza dalla stesura delle Ordinazioni di Albacina interviene un mutamento con una forma di servizio continuativo agli infermi negli ospedali di alcune città italiane. I frati cappuccini escono dai loro romitori per entrare nelle città; perché? La risposta ce la fornisce Bernardino Cioli da Colpetrazzo nella sua Ratio vivendi fratrum quando scrive che per osservare perfettamente il Testamento, se mesero negli ospedali a servire i leprosi, sì come è manifesto in Roma, in Napoli, in Genova e in altro lati, ma particolarmente in s. Giacomo delli Incurabili di Roma, il quale ospedale era quasi abbandonato […]. E fu ridotto a tanta pulitezza e a tanto bel ordine e bel governo che molti gentiluomini e signori si facevano portare al detto ospedale per godersene quella schiavitù, e per essere ammaestrati delle cose dell’anima da quei venerabili servi d’Iddio”[13].
Desiderosi di contemplazione, di solitudine, di eremo, da vivere nello specifico del frate minore e cioè “in fraternità”[14], ma allo stesso tempo contemplativi del Testamento di Francesco d’Assisi, non possono far altro che contemplare, cioè guardare alla realtà con gli occhi di Dio, e lanciarsi nel rispondere al bisogno dell’uomo reale, quello che viveva accanto a loro, così come Francesco aveva “contemplato”, guardato, quel lebbroso che gli veniva incontro e che aveva baciato.
La ricerca e il vivere concreto eremitico nell’assoluto silenzio prendono una nuova direzione: soccorrere colerosi, appestati, lebbrosi, ma con una differenza sostanziale rispetto a tutte quelle altre volte in cui i frati avevano risposto alle ricorrenti epidemie. Inizia un servizio nell’Ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma, che includeva sia un’assistenza diretta al malato, sia la direzione gestionale dell’ospedale stesso, un lavoro che oggi potremmo qualificare come “professionale”. Abbandonare gli eremi per un servizio continuativo agli infermi, è la visibile e grande caratteristica della prima generazione di frati cappuccini, frutto della loro contemplazione del Mistero del Dio fatto uomo, nato e dato per noi.
Ma l’osservanza del Testamento li spinge ad un’altra grande esigenza che stranamente non ha lasciato traccia nelle Ordinazioni di Albacina, ma che ha grande rilievo nelle Costituzioni del 1536[15]. Nei luoghi e luoghetti i primi Cappuccini sperimentano il lavoro manuale. Bernardino Cioli da Colpetrazzo, scrivendo quando si era già accesa la discussione su questo specifico aspetto, annotava, a testimonianza e difesa del modello di vita della riforma cappuccina, che quantunque noi possiamo vivere di elemosine che ci sono offerte, o veramente delle limosine mendicate, e tutto è secondo la Regola, nondimeno il più perfetto modo di vivere secondo la purità della Regola sarebbe vivere di laborizio. E questo noi lo vediamo nelli padri antichi [… ] i quali propongono nelle loro Regole [le Costituzioni del 1536] che si debba lavorare, sicome vediamo ancora del nostro serafico padre san Francesco[16].
Il nostro cronista si dilunga poi nel raccontare, partendo dalla sua personale testimonianza, come i frati si mantenessero e vivessero «delle loro fatiche»[17], ma soprattutto riferisce, con stupore, come gli stessi primi frati gioissero di queste loro fatiche.
Figura emergente, iconica, presentata da Bernardino Cioli da Colpetrazzo, è Francesco Tittelmans da Hasselt[18], letterato e dotto che per un brevissimo tempo fu anche il superiore della Provincia Romana. Egli raduna in sé gli aspetti caratteristici della prima generazione di Cappuccini. Pur essendo uomo di studio[19], abbandona i libri e gli studi e chiede di poter essere messo al servizio degli infermi e «ottenuta dunque la licenza, servì per più mesi nel detto ospitale [San Giacomo degli Incurabili] facendo il più vile offizio che vi fosse» e divenuto Vicario Provinciale «quando vedeva i frati che spendevano il tempo malamente, duramente gli riprendeva. E diceva ch’era quasi impossibile, massime a’ giovani, d’essere casti senza un continuo esercizio o spirituale o manuale»[20], ordinando che i frati imparassero un lavoro manuale[21]. Su una perfetta conoscenza dell’uomo e delle sue debolezze, questi antichi padri sanno bene che non si è capaci di una vera carità se abitualmente si vive senza fatica e della sola elemosina. Emblematiche sono le parole riferite a Francesco Tittelmans da Hasselt: «non erano capaci di elemosine que Frati che giovini et gagliardi, non essendo occupati nelli studi et nelle cose divine, come i laici, abundantemente vivevano delle elemosine senza affatigarse»[22].
Contemplazione, lavoro manuale e servizio agli infermi, sono i capisaldi dei primi cappuccini e non solo come aspetti contestativi verso l’Osservanza, ma attraverso i due specifici campi operativi, servizio agli infermi e lavoro manuale, essi vogliono sperimentare il valore povertà e il valore carità. La fonte alla quale essi attingevano non poteva che essere la preghiera e l’intensa contemplazione silenziosa, eremitica, fraterna, del Mistero.
Ma un fatto nuovo stava per verificarsi:dal 32 insino al 36 vennero del corpo della Religione e de secolari alla Congregazione più di 500 frati, imperocché, quando si seppe che la cosa era assodata e che Sua Santità non dava più orecchie agl’avversari e come haveva dato una Bolla così autentica, tutti i zelatori dell’Osservanza della regola se mossero con gran’impeto[23].
Tra il 1532 ed il 1534 vennero alla nuova riforma grandi personalità, al di là del numero elevato, quali: Bernardino Palli d’Asti e Francesco Ripanti da Jesi, due dei quattro osservanti che avevano sollecitato la bolla di Clemente VII,[24] Bernardino Tomassini da Siena detto Ochino, Eusebio Fardini da Ancona, due futuri Vicari Generali dei Cappuccini, Giovanni Pili da Fano, Provinciale dell’Osservanza delle Marche ed intransigente nemico di Ludovico Tenaglia da Fossombrone e della nascente riforma cappuccina.
Il loro ingresso farà vivere alla riforma cappuccina il secondo stato, quello «più glorioso appresso al mondo»[25], proprio per la presenza di frati «dotti gran predicatori», ma contemporaneamente si manifesterà il primo grande passaggio di mentalità, nuova, con una generazione di frati che, non di meno della prima, desidera vivere integralmente la Regola, il Testamento, la vita di Francesco e dei primi Compagni. Un desiderio non diminuito, un fervore non minore del primo, un Amore vero.
I nuovi arrivati danno inizio ad una intensa attività di predicazione, facendo conoscere e apprezzare la riforma in tutte le regioni d’Italia richiamando, in molti osservanti e non, il desiderio di seguirli[26]. È la predicazione, attività non esclusiva dei chierici – gli stessi laici predicavano «i comandamenti di Dio, alcuni esempi e delle riprensioni assai contra i vizi»[27] – che portò ad un nuovo passaggio adattivo che fissa in maniera caratteristica il secondo stato della riforma cappuccina.
Il dato rilevabile è la conclusione traumatica del doppio capitolo di Sant’Eufemia (1535-1536) con l’uscita dalla riforma di Ludovico Tenaglia da Fossombrone. Carattere duro, tenace e autoritario ebbe nei primi anni un peso notevole, se non unico, ma a lui, tuttavia, non è possibile attribuire in toto la drammaticità degli eventi e le ovvie conseguenze. Vi è un vero e proprio scontro di mentalità, di modalità per proporre e vivere il carisma di S. Francesco d’Assisi. Sono due generazioni che in maniera altrettanto vera si propongono di rispondere al desiderio di vivere ed incarnare nel concreto lo “spirito” della Regola, del Testamento, di Francesco.
Scrive, infatti, Bernardino Cioli da Colpetrazzo che in questi anni «nacque nondimeno disparer intra di padri circa al voler vivere di laboritio»[28], indicando in maniera chiara in Bernardino Palli d’Asti, Francesco Ripanti da Jesi e Francesco Pili da Fano e «in molti altri padri illuminatissimi e santissimi uomini», i responsabili del mutamento avvenuto.
Basta assai – dicevano eglino – che tutta la congregazione viva di mendicità, e si ci è qualcuno che vogli vivere delle sue fatiche, gli concediamo, acciò, non pensando di fare una congregazione di santi religiosi che attendessimo alle messe, ai santi offizi, agli studi della Scrittura e alla predicazione, facessero una congregazione di bottegai; perché nelli esercizi meccanici è forza intrigarsi assai con seculari; e sì ancor continuar il lavorare è difficile a tener il mezzo che non si precipitino tanto nel lavorare che del tutto non si estingua lo spirito…e per questo poseno nelle costituzioni che si avvertisse di non mettere il loro fine nel lavorare, ma solo lavorar tanto che si scacci l’ozio inimico dell’anima[29].
Nelle Costituzioni del 1536 compare il capitolo sul lavoro manuale, assente, come già abbiamo ricordato, nelle Ordinazioni di Albacina. Fatto che ci comprova come la discussione ed il dibattito interno erano in atto già da tempo. Definire con precisione il momento nel quale «cessorno delle Essercitij» è di difficile identificazione[30], ma non per questo non riferibile alla “nuova” generazione di frati che nello stesso tempo aveva eliminato il servizio continuativo agli infermi. Perché? Ancora una volta è Bernardino Cioli da Colpetrazzo a darci la risposta: crescendo la congregazione et venendo gli Frati che non erano così abituati nello spirito, gli venerabili Padri illuminati dallo Spirito Santo conobbero che mentre questi tali agli essercitij et al servizio dell’infermi gli sarebbe stati causa di rovina, giudicando che non fusse impresa da ognu’uno[31].
Una preoccupazione concreta porta ad eliminare anche la seconda caratteristica della primissima generazione. Molti giovani venivano alla riforma dal secolo senza il retroterra di vicende anche drammatiche che avevano vissuto i “primi padri” venuti dall’Osservanza. Non abituati, ma non per questo non meno desiderosi di vivere il carisma francescano nella sua integrità, i nuovi responsabili della riforma cappuccina sostituiscono il lavoro manuale e il servizio agli infermi con lo studio, con una forte riproposizione dell’orazione e con la re-introduzione della sua primaria caratteristica: la predicazione. «[…] Et perciò dicevano quei venerabili Padri: Assai fa essercitio chi si affatica nelle sante orazioni, santi offitij e nelli santi studij e nella predicatione»[32]. Il secondo stato della riforma opera una vera e propria trasformazione del primo modello di vita cappuccina, certamente sulla scia dei grandi predicato
Il post-Ochino
Messo in quarantena dopo il “caso Ochino” ed ancora sotto il tiro degli Osservanti che spingevano la Curia Romana a perseguire con bolle e brevi il divieto del passaggio ai Cappuccini, l’Ordine negli anni 1542-1564 è come costretto a fermarsi nel suo naturale processo di evoluzione.
Per comprendere appieno le vicende dell’Ordine bisogna considerare il quadro di riferimento generale dell’Italia negli anni 1541-1542. È il momento nel quale si assiste a molte altre crisi di questo tipo, tutte legate a personaggi che come Bernardino Ochino appartengono a quel movimento che va sotto il nome di evangelismo italiano[33].
L’evangelismo italiano ha il suo momento di splendore e di massima espressione tra il 1520 e il 1540, arco di tempo che è nello stesso tempo momento di tensione tra una volontà di riforma ed una di restaurazione e che trova le sue radici in quella aspirazione, mai sopita e da sempre attuale nella Chiesa, che è la sua continua reformatio. Il fallimento del Concilio Lateranense V, 1512-1517, nel suo tentativo di riorganizzare una disciplina ecclesiastica sul “vecchio, anzi vecchissimo, ormai, ostacolo dell’antagonismo fra vescovi e ordini mendicanti”[34], spegne quelle speranze che in esso molti uomini, quali Egidio da Viterbo (1469-1532), Jacopo Sadoleto (1477-1547), Gaetano Thiene (1480-1547), Gian Pietro Carafa (1476-1559) e Tommaso De Vio (1468-1533), vi avevano posto per una riforma generale della Chiesa.
La situazione politica e sociale percorsa da agitazioni popolari, da guerre senza fine, dall’assedio di Vienna da parte dei turchi, ma anche battuta in modo ricorrente da pestilenze e carestie, fanno crollare i sogni e illusioni di quella cultura umanista che aveva alimentato le speranze per poter instaurare una civiltà della pace.
Due grandi eventi politici, quali il sacco di Roma nel 1527 e la caduta della Repubblica di Firenze nel 1530, rappresentano i “catalizzatori d’una situazione di effervescenza e inquietudine religiosa che trova finalmente un preciso referente politico”[35], momenti che sono allo stesso tempo segni tangibili di una crisi e di insoddisfazioni precedenti.
Si assiste ad un vero cambiamento nelle condizioni di vita e nei rapporti sociali, un cambiamento che fa sorgere la domanda affinché la stessa vita religiosa venga semplificata abbandonando quelle speculazioni filosofiche e teologiche per ritornare ad affermare una pietà da esercitarsi in opere pie e rafforzata dalla lettura del Vangelo.
L’apostasia del Vicario generale getta l’Ordine in una comprensibile agitazione, anche perché da Roma giungono notizie poco rassicuranti dove lo stesso papa Paolo III sembra aver fatto profezie poco rassicuranti[36]. Il dato certo è che nel concistoro, quando già la maggioranza dei cardinali si era dichiarato per la soppressione dell’Ordine, il cardinale di Sanseverino propone, prima della definitiva soppressione, un’indagine sulla purezza della fede dei predicatori cappuccini. Accolta la proposta si delega il cardinale Pio da Carpi, protettore di tutto l’Ordine Francescano, a condurre l’indagine. In questo lavoro sarà coadiuvato da Francesco Ripanti da Jesi[37], da poco imposto come Commissario generale dei cappuccini, a causa della fuga di Bernardino Tomassini da Siena. Le prime biografie descrivono il Ripandi come il vero antagonista dell’Ochino non solo nel modo di vivere, ma nella stessa dottrina. “...Et pare que appunto per un contraposto dell’Ochino Iddio nella Religione l’havesse posto. Laonde si come quello fu famosissimo predicatore al mondo, così questo nella religione fu di tanta eccellenza nel dire, che quanti mai altri ve ne siano tutti gli ha trapassati. Maggior quasi senza comparatione fu la scienza del Jesi che quella dell’Ochino…..L’Ochino tutto il giorno trovavasi in mezzo al mondo; il Jesi tutto diletto suo haveva nella solitudine”[38].
Nella sua funzione di Commissario generale deve sorvegliare la famiglia cappuccina[39] e nello stesso tempo deve rispondere al questionario di indagine[40] inviato dalla Curia Romana e composti di diciannove domande.
I temi di indagine riflettono quelli che sono gli argomenti più discussi del momento: la grazia, la giustificazione, i sacramenti, il rapporto fra Chiesa Romana e carismi. Sono temi che si ritroveranno nelle discussioni al Concilio di Trento. Nelle risposte che Francesco Ripanti da Jesi farà pervenire alla Curia Romana si ritrovano alcune affermazioni che il Concilio stesso adotterà.
Le prime otto domande cercano di sapere come predicano i frati intorno al grande tema della giustificazione. Si inizia l’indagine con una domanda sul peccato originale che, risponde il Ripanti, ha la sua causa nella trasgressione del primo uomo ed il suo effetto nella concupiscenza. Anche per la giustificazione vengono dichiarate le cause: efficiente: la volontà di Dio; formale: la grazia o amore di Dio; meritoria: de condigno, la passione di Cristo, de congruo, nell’uomo adulto, la sua buona disposizione e le sue buone opere. All’uomo che peccando ha perso la grazia è data comunque la possibilità di recuperarla, ma non confidando nelle proprie opere, ma nell’aiuto e nella grazia divina: recte credere, assidue orare et bona operari.
Il questionario prosegue indagando sul grande tema della penitenza specificata nelle sue due modalità: uno modo virtus, species isutitiae, che espia il peccato interiormente con la tristezza, esteriormente con il digiuno o con altre forme di penitenza corporale, allo modo est sacramentum che esige la contrizione, la confessione e la soddisfazione. Sacramento che deve essere ricevuto almeno uno volta all’anno, amministrato da quei sacerdoti che ne abbiano la facoltà.
Le domande sulla confessione-sacramento introducono al secondo grande argomento che riguarda i sacramenti, il cui numero ed elenco sono dati nella dodicesima risposta.
Molto spazio, oltre al sacramento della penitenza, è dato all’Eucaristia. Francesco Ripanti da Jesi afferma che i frati cappuccini predicano la presenza vere, realiter del Christus totus, Deus homo, sub utraque specie. Nell’ultima domanda del questionario, rispondendo alla domanda sulla Messa, egli affermerà che essa “est repraesentatio quaedam iocundissima mysterii humanitatis et presertim passionis Christi”, applicabile sia ai vivi che ai defunti.
Il terzo grande blocco, gli articoli dal tredicesimo al diciottesimo, comprende le risposte alle domande riguardanti la Chiesa e la sua potestà.
Il Ripanti identifica la Chiesa militante con la Chiesa Romana nella quale sola posita est nostra salus. A capo della Chiesa è posto il Sommo Romano Pontefice, successore di Pietro, vero ed universale Vicario di Cristo che possiede la potestà ordinaria su tutta la Chiesa militante: vescovi, prelati e subditos. A questa tematica si ricollegano anche tutte le domande che trattano del digiuno e della quaresima (articolo quindicesimo), una prassi, afferma Francesco Ripanti da Jesi, istituita dagli apostoli e mantenuta dalla Tradizione. Due altri punti, sempre ricollegabili alla tematica riguardante la Chiesa, toccano i voti monastici e lo stato di verginità. Dei primi, trattati nell’articolo diciassettesimo, si afferma che sono rationabilia et meritoria, di diritto divino e osservabili con l’aiuto della grazia di Dio. Del secondo tema, trattato nell’articolo diciottesimo, se ne afferma la superiorità sulla vita matrimoniale.
Inquisiti, sospesi dalla predicazione, smarriti, alcuni cappuccini ritornarono all’Osservanza[41], altri intrapresero fughe rocambolesche per raggiungere, attraverso la Valtellina e i Grigioni[42], a “frate Bernardino”. I più invece trovarono in Francesco Ripanti da Jesi un’áncora a cui aggrapparsi.
È in questi due anni di forzata inattività che nella Congregazione si verifica “una specie di recrudescenza e di reazione contemplativa”[43].
Come abbiamo già accennato, Francesco Ripanti da Jesi è contrapposto all’Ochino, l’uno portato alla contemplazione, l’altro al servizio della predicazione, l’uno alla ricerca della solitudine, l’altro della gente.
Che il Ripanti fosse alla ricerca della contemplazione ci è testimoniato da una notizia che solo Mattia Bellintani da Salò riporta. Accolto fra i cappuccini negli anni 1532-1533, in deroga al divieto vigente, era ritornato agli osservanti perché Ludovico da Fossombrone “veramente non havea lo spirito della contemplazione” essendo tutto il giorno occupato nella difesa della “nuova riforma” “non poteva mai haver quiete, et così ne anco di fuori quella mortificatione dello spirito che il Jesi harebbe desiderato”[44]: Roma, poi, non era il luogo più adatto alla contemplazione.
È questa in definitiva anche l’opposizione all’Ochino che pur avendo un’eloquenza superiore, era “fredda...et di poco frutto” al contrario di quella del Ripanti che era “tutto fuoco” perché la predicazione nasceva dalla contemplazione e dalla preghiera[45].
Francesco Ripanti da Jesi mentre conferma l’ortodossia dei frati, diventa anche maestro di contemplazione, insegnando “a' frati la via della perfettione, e singolarmente gli istruiva del modo di orare e contemplare, standosene lungamente ne’ luoghi, ove faceva venire quanti frati vi potevano capire per insegnare molti insieme”[46].
Purificati al loro interno, costretti all’inattività, ma aiutati a recuperare lo spirito di contemplazione fraterna, i cappuccini, all’inizio del Concilio di Trento, affrontano un passaggio adattivo che li conduce a rivedere il modello originario.
Una prima seppur piccola sfumatura del cambiamento che investe la “riforma” cappuccina in questi anni è rilevabile nella questione delle suppellettili liturgiche. Nella Ratio vivendi fratrum, Bernardino Cioli da Colpetrazzo annota come i primi frati “usarono per lungo tempo i calici di stagno, ma perché molto macchiavano i corporali, et per stimolo che non si usasse poca riverenza al SS. Sacramento, gli lasciarono et poserono nelle Costitutioni che si potesse havere due calici per luogo con la sola coppa d’argento”[47]. È un adattamento imposto dall’esterno, quasi una rinuncia allo spirito che li aveva mossi all’inizio delle loro esperienza. La loro povertà e semplicità, che nasceva da un’intensa adorazione del mistero dello croce come gratuità di salvezza, poteva essere scambiata per polemica, ma soprattutto per condivisione delle idee riformistiche anti-romane.
La terza grande figura che segna questo periodo della “riforma cappuccina” è Bernardino Palli d’Asti (1485-1557)[48], considerato dai primi cronisti il primo vero Vicario dell’Ordine[49]. Con lui infatti vengono redatte le prime Costituzioni dell’Ordine e a lui si deve, nel giugno del 1536, un memoriale nel quale difende la possibilità di passare dall’Osservanza ai Cappuccini, poiché è solo fra questi ultimi che la Regola viene osservata perfettamente[50].
Bernardino Palli d’Asti è Vicario generale dell’Ordine prima e dopo la bufera dell’Ochino (1535-1538; 1546-1549) vivendo dal vertice il travaglio della crescita della “riforma cappuccina”, dagli anni posteriori all’uscita di Ludovico Tenaglia a quelli della ritrovata espansione che portava con sé altri inevitabili problemi.
I giudizi da lui espressi in relazione ai mutamenti che sono avvenuti o che stanno maturando dentro la “riforma” sono documenti importanti che ci permettono di capire come una generazione di frati, la sua, vive e valuta il cambio di mentalità.
Di vita austera egli aveva operato, nel suo primo mandato, per equilibrare la vita dei frati da quegli eccessi che caratterizzavano la primissima generazione, con un’opera che entrava a regolare la piccolissima quotidianità[51]: dalla minestra che doveva essere condita a sufficienza, al vino che doveva essere temperato, cioè annacquato, nella giusta misura.
Era intervenuto anche a regolare la preghiera per dare dei momenti comuni e uguali per tutti, smascherando chi, con la scusa di stare sempre in orazione, si ritirava nella propria “cella a far sporte o crocette” ed evitando in questo modo di assolvere ai lavori comuni quali quelli dell’orto, della cucina o dell’assistenza agli infermi. Nella polemica, che vedremo nel capitolo secondo, dell’eliminazione dell’esperienza del lavoro manuale negli anni 1535-1536, riafferma con forza come l’impegno nelle occupazioni, anche quelle domestiche, non deve spegnere “il gusto dell'oratione”[52].
Ma è pochi anni prima della sua morte, al momento dell’approvazione delle nuove Costituzioni, quelle del 1552, che Bernardino d’Asti ci dà una valutazione personale delle mutazioni che sono intervenute in questi anni post-Ochino.
È un giudizio critico e severo che manifesta tutta la sua amarezza: “Dunque hora noi siamo venuti tanto innanti, quanto si può venire; ogni poco che passa più, in alcune cose si farebbe contra la Regola; insino adesso ci habbiamo havuta una gran’ siepe, nè mai si è toccata la Regola; hora noi siamo in su quel che la Regola ci concede, che prima si faceva più che la Regola non comanda”[53].
È un’indicazione chiara e precisa di come i rapporti dentro la “riforma cappuccina” sono cambiati ed una generazione di frati si è ormai sostituita alla prima.
Temporalmente è il suo ultimo intervento. Bernardino Palli d’Asti ha appena terminato il suo terzo mandato come Vicario generale (1546-1549) durante il quale ha continuamente lottato per mantenere alto l’ideale che la sua generazione aveva cercato di vivere e che era stato condensato nelle Costituzioni del 1536.
Tra i fattori che intervengono in questi anni a mutare il clima della “riforma cappuccina” c’è in primo luogo la ritrovata vitalità e crescita numerica. Tuttavia sarà la provenienza dei nuovi venuti ad avere un’incidenza maggiore nel cambiamento dello stile di vita dei frati.
La grande maggioranza dei candidati proviene ormai dal secolo e non più dalle file dell’Osservanza. Essi hanno perso la coscienza di essere dei riformatori dell’Osservanza e si considerano oramai un ramo nuovo, della famiglia francescana. La contrapposizione si stempera e la ricerca dell’autentico vivere francescano ha ora una sua nuova struttura.
Bernardino Palli d’Asti, in qualità di Vicario generale, rivolgendosi con una lettera a tutti i frati, lettera che è considerata la prima “Lettera Circolare” dell’Ordine[54] tracciava un ritratto non solo della spiritualità del frate cappuccino, ma di come doveva essere la concreta consistenza del frate “riformato”. A modello poneva la sua generazione.
La fisionomia del frate cappuccino è costruita sul trinomio: povertà, orazione e carità. Dove la carità, quale virtù teologale, è il perno ed il principale fondamento sia della vera orazione che della vera povertà, mentre l’orazione e la povertà, unite all’osservanza integrale della Regola, sono i segni concreti e riscontrabili dell’autentica carità. La carità, cioè la carità-virtù, non può rimanere nascosta e deve esplodere nella carità fraterna, cioè nella pratica dell’amore fraterno.
La generazione di Bernardino Palli d’Asti, respira e vive una reciproca conoscenza, dove i frati, pochi di numero, si conoscono e si scambiano quelle attenzioni che hanno la loro sorgente solo e solamente nella carità fraterna. Povertà, orazione e osservanza della Regola diventano i segni visibili, che non devono solo essere predicati, ma vissuti per poter dire: lì vi è il vero frate cappuccino.
Ma oltre a tracciare la vera fisionomia del frate cappuccino[55], la lettera fa emerge la chiara testimonianza delle nuove tensioni che l’Ordine sta affrontando. Egli, infatti, lancia il suo guai verso “quei frati capuccini, li quali cercano di allargare il vivere nostro. Et in verità non sono frati minori di S. Francesco, ma più presto di F. Elia e, come dice l’apostolo inimici della croce di Christo, Dio nostro, et destruttori della nostra congregatione”.
È evidente che, ancor prima della revisione delle Costituzioni, inizia un cambiamento all’interno della fraternità ed il desiderio di mantenere l’ideale della sua generazione spinge Bernardino Palli d’Asti a lanciare il suo guai contro chi attenta alla povertà. Il paragone non può che corre verso frate Elia, figura nella quale tutta l’Osservanza ha cristallizzato l’elemento negativo.
L’ammonizione di Bernardino Palli d’Asti tende a richiamare l’osservanza della povertà che è al tempo stesso provvisorietà e semplicità di vita, capacità a lasciare i luoghi, a non rimanere legati sempre alle stesse persone, trasparenza di vita che lasci vedere lo spirito con il quale si agisce eliminando quelle doppiezze che nella prima parte della lettera ha così ripetutamente sottolineato.
Una povertà che doveva risplendere soprattutto nelle abitazioni, ma che le esigenze concrete della vita, frati anziani, malati, deboli…., faceva cadere sotto i colpi dell’amore fraterno. Tutto ciò appariva agli occhi di Bernardino Palli d’Asti un vero e proprio tradimento.
Un ultimo dato che svela come questi anni siano anni di cambiamento nei quali Bernardino Palli d’Asti diventa il paladino di una parte, è la sua piccola dichiarazione sul modo di vestire, redatta nel 1550[56].
Educato dentro l’Osservanza egli conosce tutte le lotte intraprese sulla questione del vero abito di San Francesco, non ultimi i cappuccini stessi, si lascia andare, con una certa gravità all’affermazione che “le Religioni dal vestire han sempre cominciato a rilasciarsi”[57].
Il suo memoriale, prende posizione contro quella abitudine che stava prendendo piede nell’Ordine di portare più di due panni e, rifacendosi alla Regola, sentenzia che quel frate che porta tre panni senza necessità, “pecca mortalmente”.
Elenca quindi, con vera minuzia e precisione, le vere necessità: “Prima: quando piove, essendo in viaggio. Seconda: quando il Frate ha provato portare due tonache fodrate, et non può stare sano... Terza: è necessità secondo alcuni, quando i Frati camminano per paesi di eccessivo freddo”. Immediatamente si avverte che quest’ultima necessità non è da lui condivisa perché subito aggiunge: “contro questo è l’esperienza da me fatta e da miei compagni, con li quali sono andato dieci invernale o circa ed siamo passati per paesi d’eccessivo freddo, per monti, pioggie, neve e ghiacci, sempre tutti con 1’habito solo et il mantello”[58].
Gli adattamenti necessari, conseguenza di differenti situazioni, anche climatiche, nelle quali i frati si vengono a trovare, muovono Bernardino d’Asti a difendere il modo di vestire della sua generazione. La revisione delle Costituzioni avvenuta nel 1552, con i dati, o meglio con le omissioni rispetto a quelle del 1536, segneranno il confine tra una generazione ed un’altra.
Durante il Concilio
Il periodo dal 1542 al 1558.
Come abbiamo ricordato nel primo capitolo, sono i due grandi moderatori, Francesco Ripanti da Jesi e Bernardino Palli d’Asti, che si preoccupano di far riassorbire questa pericolosa situazione, ma per fare ciò devono rinchiude l’Ordine in due anni di preghiera e di solitudine.
Bloccata la libera predicazione che era comune nei primi anni e nella quale erano impegnati tutti i cappuccini, laici o chierici[59], si aprirono degli ambiti di formazione la cui orientazione unica era alla predicazione.
L’istituzione di case di studio, con veri e propri programmi, arriveranno solamente dopo Trento, trovando la loro collocazione giuridica nella legislazione del 1575.Ciò che in questo particolare momento appare in germe e che avrà un’esplosione negli anni successivi, è la tendenza alla clericalizzazione.
Le Ordinazioni del 1549 dichiarano che “nessun laico abbia libretto alcuno, eccetto la Regola volgare”[60] Più esplicite, prevedendo anche delle sanzioni penali, sono le Ordinazioni del 1552, “Nessun frate in alcun modo insegni leggere o scrivere a’ laici, né in secreto né in publico; e chi insegna non possa essere assoluto di tale disobedienza se non dal P. Vicario Provinciale con una buona penitenza”[61]
Le cronache inoltre riportano la preoccupazione di Bernardino Palli d’Asti nel vedere “i frati laici che si davano all'ozio e non volevano fare gli offizi della cucina, degli orti e altri”[62].
Si era nella necessità di dare una certa preparazione al frate predicatore, non lasciando quindi all’improvvisazione il servizio della predicazione. Ma allo steso modo si constata che non tutti i chierici automaticamente diventavano predicatori. Lo studio e l’orazione erano diventati, attraverso il governo di Bernardino Palli d’Asti e Francesco da Jesi i sostituti conventuali del servizio agli infermi e del lavoro manuale. E coloro che non erano chierici, coloro che vengono comunemente indicati come laici, quali sostituti potevano avere?
La conclusione della Ratio vivendum fratrum di Bernardino Cioli da Colpetrazzo, ci apre alla comprensione di quale doveva essere stato il travaglio del passaggio e affermava che” i nostri Laici assai bene spendono il tempo quando si affatigano nelli essercitij et offizij della Religione”[63].
L’Ordine appare già diviso in due distinte parti, una delle quali, quella dei chierici si avvia a prendere il predominio. Anche se il cronista Mattia Bellintani da Salò dichiara che “sotto F. Bernardino d’Asti e F. Eusebio d’Ancona, suo successore, andò quietamente la Congregatione profittando e crescendo in numero e perfettione”[64], la revisione delle Costituzioni avvenuta nel 1552 sotto il governo di Eusebio Fardini da Ancona (+ 1569), denuncia un’evidente evoluzione nella mentalità dei frati.
Nel secondo stato il governo è ancora nelle mani di uomini che provengono dall’Osservanza, carichi della loro idealità, ma che ogni giorno si scontra con le esigenze concrete di una nuova rapida crescita. Gli adattamenti necessari, studi, case più vicine alle città per la presenza di anziani, suscitano lo sconforto di coloro che venivano dall’esperienza precedente.
I segnali di una possibile revisione delle Costituzioni, fatto che come abbiamo visto si verificò puntualmente, spinsero Bernardino Palli d’Asti a lanciare il suoi guai verso quei frati che cercavano “di allargare il viver nostro”[65]. Il numero crescente dei frati e il fervore in diminuzione, costituiranno la sua principale preoccupazione.
Poco prima di terminare il suo ultimo mandato da Vicario generale, aveva pubblicato una “dichiarazione intorno al portar tre panni…...perchè molti Frati desiderosi di osservare intieramente quanto hanno promesso bramano sapere come s’intenda il precetto della Regola circa il vestire”[66]. Egli afferma che la Regola permette di portare due panni, mentre pecca mortalmente chi porta due panni senza una vera necessità. Egli spiega che uno dei due panni, osservando in questo perfettamente la Regola, può essere sostituita dal mantello, ma mai, in nessun caso, si possono portare due panni e il mantello.
Basandosi poi sulla Leggenda dei tre Compagni, su antichi dipinti in cui è raffigurato San Francesco e sulla reliquia del mantello che si trova nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Tivoli, assicura che Francesco e i suoi primi compagni portavano “il mantello con l’habito senza alcuna tonica”. Il secondo panno venne posto nella Regola da Francesco, per tranquillizzare la coscienza di chi, debole e malato, non poteva portare il solo abito ed il mantello.
Al centro della polemica è il modo di vestire, il fervore imitativo di Francesco che aveva animato i cappuccini della sua generazione e così Bernardino Palli d’Asti è portato a difendere con decisione la sua esperienza. Contro un fervore in continua diminuzione sprona i più fervorosi a non curandosi “di quelli che si ridono di noi, perché li medesimi si ridono di molte cose de’ quale dovrebbero piangere”[67]
Lo stesso clima di preoccupazione, al quale si aggiunge una certa punta polemica, lo si ritrova nella Ratio vivendi fratrum di Bernardino Cioli da Colpetrazzo. Parlando del vestire dei primi cappuccini e appoggiandosi in parte sulla dichiarazione di Bernardino Palli d’Asti, ma senza citarlo, con rabbia afferma che “quegli che dicono esser’ più conformi alla Regola et secondo che usavano quei primi Padri il portare la tonaca che il mantello, di gran’ longa si ingannano”[68] Bernardino da Colpetrazzo riafferma che l’esempio dato da San Francesco e dai primi compagni, che il primo gruppo di cappuccini ha fedelmente incarnato, è stato quella di un abito e di un mantello.
Dal 1542 al 1558, i cappuccini attraversano un periodo che va dalla reclusione forzata causata dalle vicende dell’Ochino, alla ritrovata vitalità che li porta di nuovo nel campo della evangelizzazione, passando attraverso una rinnovata crescita numerica.
Le due identità non potevano rimanere indifferenti nella comune convivenza, il confronto che nasce porta ad un nuovo modello. Se la prima generazione, vedendo il calo di fervore nei giovani venuti alla “riforma” in questi anni, è preoccupata di ribadire il proprio modello, la nuova generazione che pure ha ricevuto tutta la propria formazione nei cappuccini, si affaccia sulla scena e reclama di poter vivere lo stesso carisma, ma con modalità differenti, ma non per questo meno valide.
I mutamenti degli anni 1558-1575.
L’anno 1558, seguendo la divisione di Mattia Bellintani da Salò, apre il terzo stato perché: “il governo di quei Padri che erano venuti dall'Osservanza passò a quelli del secolo e da altre Congregazioni erano venuti”[69].
Il 27 maggio 1558 era stato eletto Vicario generale Tommaso Gnotti da Città di Castello (+1576) il quale era venuto dal secolo. È il periodo caratterizzato dallo scontro tra frati vecchi[70] e quelli della nuova generazione, ma anche il momento nel quale il governo passa da coloro «che erano venuti dall’Osservanza a quelli del secolo e da altre Congregazioni erano venuti»[71].
I frati giovani sentirono maggiormente alcune problematiche come quella dello studio; a quanto ci riferisce Mattia Bellintani da Salò il nuovo Vicario generale desiderava assai che i giovani facessero profitto ne studi, dicendo che egli havea provato quanto importava la dottrina, perché egli non havea studiato fuor che le lettere humane al secolo, et venuto provetto sacerdote alla Religione non havea potuto attendere allo studio[72].
Ma allo stesso tempo era preoccupato che tanto accrescimento incominciava a partorire tiepidezza in alcuni, et se ne cominciavano a trovare di difettosi, usò più rigore del solito in punire i delinquenti[73].
Ed è a causa di questo suo rigore che, richiamato in pieno Capitolo generale dal suo primo Definitore, Eusebio Cardini d’Ancora, dovette «per penitenza che non so quante volte lavasse le scodelle»[74].
Il governo di Tommaso Gnotti da Città di Castello è dunque indicativo dello scontro in atto, delle mormorazioni e delle denuncie anonime. Fatto che ha interessato anche il cronista Mattia Bellintani da Salò che ammonisce «quanto importi che un Prelato debba maturatamene procedere quando gli vengono accusati i sudditi suoi; et quanto il diavolo perseguiti la pace e l’unione dei fratelli»[75].
Se il gruppo dei frati giovani cercava di rispondere alle esigenze e ai segni dei tempi: crescita numerica, case di studio, nuovi ambiti di apostolato, frati anziani e malati da accudire, con l’accomodar i conventi «già troppo lontani, presso terre et città»[76], il gruppo dei frati vecchi rispondeva attraverso la riproposizione delle figure carismatiche della prima generazione quale era stato Francesco Ripanti da Jesi che molto biasimava gl’edifici sontuosi e diceva che il murar’ nella Religione è cosa pericolosa et quasi impossibile che (non) ve se offenda la povertà […] imperocché subitamente che un Frate entra nelle fabriche, subito l’entra il demonio addosso et gli tolle il cervello et le fa far’ contra la povertà[77].
I due decenni che seguirono la chiusura del Concilio di Trento (1565-1581), segnarono al contrario il momento di una rinnovata e fervorosa ripresa. Si registra, infatti, una crescita numerica[78], ma soprattutto una nuova e viva presenza nella Chiesa con un ritrovato impegno pastorale[79].
Da rilevare che fu in questi stessi anni, quanto erano passati quarant’anni dal momento della loro fondazione, che i frati cappuccini si sentirono spinti a raccogliere le loro memorie storiche per non perdere il contatto vivo con l’esperienza delle loro origini. I primi tentativi, opera di Mario Fabiani da Mercato Saraceno, sono per lo più occasionali e destinati ad un pubblico esterno alla comunità[80].
Ma non erano simili Relazioni che il nuovo Vicario generale, Girolamo Pratelli da Montefiore[81] (1575-1581), aveva in animo di proporre alla lettura dei frati. Scrive, infatti, nella lettera “Alli divoti lettori”, presentazione dell’opera ormai finita e da lui composta, Vite di alcuni frati cappuccini[82] che benché io sapessi il padre frate Mario da Mercato Saraceno di buona memoria (come anco prima di me degnamente fu vicario generale della nostra congregazione) aver bellissimo stile tessuta un’istoria nella quale racconta l’origine e progresso di essa congregazione sino a questi nostri tempi, non di meno perché il detto padre non s’estende se non in poche cose a narrar la vita e fatti de’ frati particolari […] ho pensato non essere superfluo tal’impresa di scrivere le cose più notabili de’ frati particolari[83].
Egli vuole proporre alla fraternità le biografie dei frati del primitivo e originario gruppo e così: «benché tardi, cioè verso la fine del detto mio officio», si affretta a sistemare tutto quel materiale che «alcuni padri più antichi», gli avevano mandato sollecitati dal suo desiderio di raccogliere, conoscere e far conoscere.
Tra le mani si ritrova l’opera di Bernardino Cioli da Colpetrazzo, un materiale già ben strutturato che Girolamo apprezza e condivide. Con qualche aggiunta è pronto per essere divulgato e proposto alla lettura dei frati. Scrivendo a Bernardino Cioli da Colpetrazzo, il Vicario generale spera che la lettura sarà di grand’utilità, e credo che se a Dio piacerà che si legga tra Frati, come è animo mio si faccia, farà grandissimo frutto e aprirà le menti, e darà grand’animo a quelli che sono inchinati alla pura e vera Osservanza della Regola[84].
Lo scopo di Girolamo Pratelli da Montefiore è quello di mettere nel cuore dei suoi frati il desiderio di vivere l’Osservanza della Regola, la povertà in primo luogo, nello stesso solco che avevano tracciato quei «molti santi frati» i quali avevano dato inizio alla “riforma cappuccina”. Poiché vedendo che la memoria di tali cose andava mancando non senza danno dei posteri, pensai per la gloria di Dio (dal quale procede ogni bene) e per utile di tutti i nostri frati presenti e futuri, raccogliere e far mettere in scritto le cose più segnalate delle quali io potessi aver probabile notizia, tanto la santità dei costumi, come circa i miracoli dei nostri frati già passati da questa vita, acciò dalla santità dei costumi li frati potessimo conoscere come in uno specchio la pura osservanza della nostra Regola e la vera vita spirituale, quale dovevano tenere[85].
Accanto a questo scopo primario, le biografie degli “antichi padri” dovevano richiamare e riaffermare l’identità originaria della “riforma”, ma soprattutto evidenziare la possibilità di viverla nell’oggi del suo tempo.
Che non esistesse un’unanimità di consensi sul modello proposto ne è testimonianza la punizione che fu inflitta allo stesso Girolamo Pratelli da Montefiore durante il Capitolo generale del 1581, ad un anno di distanza dalla pubblicazione della Divota Historia di Bernardino Cioli da Colpetrazzo.
Il Vicario generale veniva privato di voce attiva e passiva «perché si trovò che voleva fare una riforma, i cui frati chiamava maddaleniti, e ciò faceva con buonissimo zelo, e fine, perciò egli sopportò pazientemente il tutto, ne mai si volse scusare»[86].
La “crisi” maddalenita si rivela come l’apice di quelle tensioni che si erano venute accumulando già a partire dal generalato di Eusebio Fardini da Ancona (1552-1558), ma ancor più esplicitamente negli anni di Mario Fabiani da Mercato Saraceno (1567-1571).
Nella sua Historia Capucina, Mattia Bellintani da Salò, mentre traccia un giudizio sul governo di quest’ultimo, presenta al contempo un quadro evolutivo della “riforma”. Egli – scrive il Bellintani – nel suo governo, si come era di tal natura, fu piacevole e benigno, più forse di quello che al’hora havea bisogno la Religione, la quale crescendo in moltitudine, havea bisogno di freno, perché la moltitudine et massime di giovani facilmente scorre – se non è frenata – nelle rilassationi. S’era già cominciato a lasciarsi alcuni luoghi, i quali erano lontani dalle città et fabbricarne de più vicini, il che seguito si è poi man mano con alcuni altri, perché crescendo i frati era difficile portar per tanti la limosina a spalla; non si potevano havere per gli infermi i medici, né commodamente se gli potevano fare le convenienti provisioni. Né il tener gli hospitji nelle città in rimedio della lontananza de luoghi era stimato bene[87].
Questi adattamenti, conseguenza di una mutata situazione interna dovuta a vari fattori quali l’aumento numerico, il trovarsi in comunità frati anziani e malati, l’avere comunità numerose, comportarono una reazione che portava dentro di sé sia una valenza di contestazione verso l’inevitabile istituzionalizzazione sia un desiderio, peraltro mai totalmente sopito, di un ritorno ai momenti degli inizi della “riforma”.
Si sviluppò segretamente, ma non senza il benestare e l’approvazione paterna del Vicario generale, Girolamo Pratelli da Montefiore, un movimento i cui aderenti si autodenominarono “maddalene”. Alcuni trapportati da un gran desiderio di perfettione, si accordavano insieme per gli conventi a far qualche cosa di più del ordinario sotto il nome et perfettione della Maddalena, ordinando fra di loro alcuni avertimenti da osservarsi, et istituendosi fra di loro alcuni particolari superiori. Et il tutto secretamente facendo. Et quantunque tutto facessero secretamente, crebbe nondimeno subito questo loro istituto, et si sparse quasi per tutte le Provintie. Né parve al Generale di impedirlo, più tosto consolandosi di vedere così generalmente tanta buona volontà et tanta prontezza a far bene nella Religione[88].
Le “maddalene”, volendo «fare qualche cosa di più dell’ordinario», cercarono una vita di penitenza, di contemplazione e di fraternità eremitica, ma soprattutto si dettero delle nuove regole e dei nuovi superiori creando una vera e propria gerarchia parallela. Questo fatto suscitò, come era prevedibile, la reazione dei frati riuniti in Capitolo generale. I padri del Capitolo Generale più sodamente et con prudenzia considerando che ciò havrebbe potuto generare degli inconvenienti et che quegli ordini loro non erano di cose relevanti, essendo che la vita comune tutto quello abbraccia che è giovevole a camminar nella perfettione, vietarono cotali ordini come cosa di molto pericolo e di pochissimo e nium frutto, compiacendosi bene che i Frati tutti sotto lo stendardo delle ordinarie Costitutioni fatte da Padri vecchi, dotti e santi con grande spirito et prudentia, si studiassero di camminare innanzi continovamente verso i supremi gradi della perfettione[89].
1581-1596 l’ordinario vivere
La punizione inflitta al Vicario generale segnò la “sconfitta” di un modello, di un’idea e allo stesso tempo la sconfitta di una generazione di uomini e frati che in questo modello credevano. La guida dell’Ordine passava ora ad una nuova generazione di frati non più provenienti dall’Osservanza, ma totalmente dal “secolo”. Con una formazione ricevuta all’interno della “riforma” cappuccina.
La sostituzione del cronista ufficiale dell’Ordine, Bernardino Cioli da Colpetrazzo, avvenuta nel Capitolo generale del 1587, sanciva il definitivo passaggio dai Cappuccini del primo Cinquecento, gli anni della preparazione e celebrazione del concilio di Trento, a quelli del secondo Cinquecento che sull’onda del rinnovamento conciliare si sentivano altresì strumenti vivi della Chiesa. Lo stesso Bernardino Cioli da Colpetrazzo, scrivendo al Duca di Acquasparta, Federico Cesi, al quale dedicava tutta la sua opera, si lasciava andare ad una considerazione amara: «già la nostra Congregazione non ha più bisogno di me»[90], facendo del suo sfogo l’emblema dello sconforto di tutta quella generazione di frati che si vedeva messa da parte. Il testimone passava a Mattia Bellintani da Salò e al nuovo modo di guidare la “riforma”.
Se Bernardino Cioli da Colpetrazzo raccontava la storia dei Cappuccini privilegiando i fatti ed i frati dei primi due stati, affermando che il secondo stato fu sicuramente «il più glorioso appresso il mondo», senza peraltro mancare di dare un giudizio su quegli anni e giudicando quella gloria effimera[91], Mattia Bellintani da Salò leggeva la storia dei Cappuccini nel grande quadro del clima ecclesiale rinnovato dall’evento conciliare[92]. Mattia Bellintani da Salò vive il terzo stato della riforma cappuccina.
Il primo stato per lui fu quello della preparazione dove non ci fu un vero e proprio controllo delle vocazioni, dove non esistettero delle vere strutture istituzionali. Una preparazione che andava di pari passo con un’altra ben più grande preparazione di “riforma”, tanto da far esclamare a chi incontrava i Cappuccini «o che è la fine del mondo, o che gran cose hanno da essere […]. Et perché fu singolar concordia e conformità fra questa francescana riforma e quella della Chiesa, essendo la riforma della francescana Religione principio, mezo e segno di quello della Chiesa universale […]. La religione di S. Francesco ha sempre con gli Concilii generali avuto congiuntura»[93].
Il secondo stato (1535-1558), è quello nel quale si diè forma alla Riforma e pigliò vero stato di religione, governandosi religiosamente, facendosi i capitoli generali et provinciali et le ordinarie visite, et reggendo Prelati dotti e santi con le costituzioni ben ordinate e dichiarate[94].
Continuando il suo parallelismo con il Concilio di Trento, il Bellintani afferma che il primo Capitolo generale (1535-1536) coincide con la Bolla di convocazione del Concilio stesso[95].
Il terzo stato, quello che interessa più da vicino il nuovo cronista dell’Ordine, cominciò […] l’anno 1558, nel quale il governo di quei Padri che erano venuti dall’Osservanza passò a quelli li quali dal secolo e da altre Congregationi erano venuti […]. Questo stato diè termine al venire alla Riforma Capuccina degli Osservanti, perché più volte fugli posto con Bolle impedimento; et quantunque tal volta egli tal impedimento si levasse, pochi nondimeno ne venivano, ma molti più pochi riuscivano bene, perché il più se ne ritornavano onde erano venuti. I Conventuali non così, perché tutti ordinariamente riuscivano benissimo[96].
Gli Osservanti sono ritenuti dal Bellintani «l’origine» della riforma cappuccina, ma la crescita numerica e l’espansione geografica avevano portato a delle sostanziali modifiche. La prima evidentissima era stato il «cessare quel primo fervore et ardore dell’austerità» che aveva caratterizzato la prima generazione, ma adesso nella comunità ci si ritrova con un numero sempre crescente di frati anziani e malati; perciò, annota il nostro cronista, «è stato mestiere accomodare i conventi già troppo lontani presso alle terre et città»[97].
Questo comportava modificazioni, ma non scadimento della tensione vitale che aveva mosso ad abbracciare la vita religiosa. Commenta Mattia Bellintani da Salò: così la vita, i luoghi e gli habiti et tutto il resto si è ridotto ad uno stato mezano et ad un religioso corso; onde con l’osservanza sostanziale della Regola viver possono quelli ancora, li quali non hanno bollimento di spirito come haveano i primi fondatori, et tutta via quelli hanno quanta commodità si bramino, li quali con ardente spirito procacciano la perfettione della virtù et della evangelica, li quali ricoperti dell’ordinario vivere il quale essere nel di fuori commune a quelli ancora li quali contenti di quel che è necessario per salvarsi tanto alto non aspirano, seguono più sicuri il santo istituto di conseguire la vera santità appresso al Datori celeste, il quale nell’ascoso vide[98].
Il Bellintani nella difesa dello «stato mezano» e «religioso corso», lasciando trasparire la sua esperienza personale[99], affermava come i Cappuccini potevano vivere le strade della santità anche nell’«ordinario vivere».
Due sensibilità? Due schemi letterali? O non forse due generazioni di frati con due modelli ben precisi! Le due posizioni storiografiche fanno emergere il travaglio e lo scontro tra frati vecchi e frati della nuova generazione che non di meno vogliono vivere con autenticità il carisma della “riforma cappuccina”, non per adeguarsi ai tempi, ma per non lasciare il carisma dentro il museo della storia.
Ulteriori considerazioni su alcuni aspetti concreti dello scontro possono mettere in luce come tutte le generazioni di frati tendevano all’autenticità e all’essere presenza viva nel corpo vivo della Chiesa. La loro santità non era per sé stessi, ma per un Bene più grande.
Il Capitolo generale dell’Ordine, tenutosi a Napoli, aveva eletto, il 27 maggio 1558, Tommaso Gnotti da Città di Castello (+1576) Vicario generale, il quale era venuto ai cappuccini dal secolo.
Il periodo del suo governo è caratterizzato dallo scontro fra frati vecchi[100] e frati della nuova generazione. Questi ultimi sentirono maggiormente alcune problematiche come era quello dello studio e stando a quanto ci riferisce Mattia Bellintani da Salò, il nuovo Vicario generale “desiderava assai che i giovani facessero profitto ne studi, dicendo che egli havea provato quanto importava la dottrina, perché egli havea non havea studiato fuor che le lettere humane al secolo, et venuto provetto sacerdote alla Religione non havea potuto attendere allo studio”[101].
Ma ugualmente lo stesso era preoccupato che “tanto accrescimento incominciava a partorire tiepidezza in alcuni, et se ne cominciavano a trouvare di difettosi, usò più rigore del solito in punire i delinquenti”[102]. Ed è a causa di questo rigore che, richiamato in pieno Capitolo generale dal suo primo Definitore Eusebio Fardini d’Ancona, dovette “per penitenza che non so quante volte lavasse le scodelle”[103].
Il vicariato di Tommaso Gnotti da Città di Castello è indicativo dello scontro in atto, delle mormorazioni e delle denunce anonime. Mattia Bellintani da Salò, lasciando trasparire la sua esperienza, ammonisce “quanto importi che un Prelato debba maturatamente procedere quando gli vengono accusati i sudditi suoi; et quanto il diavolo perseguiti la pace et unione dei fratelli”.[104]
Egli aveva vissuto in prima persona, tra il 1565 e il 1568, lo scontro tra frati vecchi e frati giovani che interessò la Provincia di Milano, in quanto essendo definitore della stessa, fu coinvolto nella deposizione del Provinciale, Apollonio Porcellagra da Brescia. Il motivo del contendere erano le fabbriche, cioè la costruzioni di molti e nuovi conventi.
Il gruppo dei giovani cercava di rispondere alle esigenze del momento, crescita numerica, case di studio, nuovi ambiti di apostolato, frati anziani da curare, accomodando “i conventi già troppo lontani, presso terre et città”[105], mentre il gruppo dei vecchi rispondeva attraverso la riproposizione delle figure carismatiche della prima generazione, quali Francesco Ripanti da Jesi che molto biasimava gl’edifici sontuosi e diceva che il mutar’ nella Religione è cosa pericolosa et quasi impossibile che (non) ve se offenda la povertà... imperochè subitamente che un Frate entra nelle fabriche, subito l’entra il demonio addosso et gli tolte il cervello et le fa far’ contra la povertà”[106].
I conflitti degli anni 1575-1596.
Il Capitolo del 1573, aveva indicato una revisione delle Costituzioni, per adeguarle alle direttive conciliari, introducendo di fatto molte norme giuridiche che ne diventano la caratteristica.
In questi anni l’afflusso di vocazioni, provenienti per la maggior parte del secolo, è irresistibile e le molteplici iniziative studiate per porvi un freno non hanno avuto nessun risultato[107].
È il momento nel quale la “nuova riforma” va al di là delle stesse aspettative ed intenzioni dei primi cappuccini. Superati i confini naturali d’Italia, i cappuccini iniziarono a ramificarsi in Europa aprendo le prime case in Francia.
Contemporaneamente si apprestarono ad entrare nella lotta contro la riforma protestante e contro la pericolosa avanzata dei turchi[108].
I Vicari Generali che si susseguono in questi anni, in particolare Girolamo Pratelli da Montefiore, sono preoccupati di questa intensa attività apostolica che va via via crescendo intaccando, in certo qual modo, il clima di quiete dell’Ordine e notando il forte calo di fervore tra i nuovi entrati. Loro principale preoccupazione!
Bernardino Cioli da Colpetrazzo, nella sua interpretazione storiografica, è chiaro nell’indicare come il numero elevato sia direttamente proporzionale con la perdita di fervore.
Prendendo a modello la figura carismatica di Francesco Ripanti da Jesi afferma che egli stesso ha sentito dire che nessun altra causa è più rovinosa “alla Congregazione quanto la ricezione di Frati” dove “non basta di considerare la buona volontà de’ giovani, imperochè, essendo molto delicati, molto giovinetti, deboli, infermi et simili, non si debbono ricevere, perché si obligano a quello che non possono, che è l’andare scalzo, mal vestito, diggiunar’ spesso, sopportare le fatighe che porge la Religione per esser’ povera. Al contrario ne riesce tutto il contrario”[109].
Come era avvenuto negli anni precedenti nei quali erano scoppiati più evidenti i contrasti a motivo delle fabbriche considerando che “dalla moltitudine ne segue un altro inconveniente, che bisogna fare li luoghi grandi vicini alle città più commodezza di questi tali”, in questi anni si ravvivano le discussioni perché se ne rivelano le conseguenze e cioè che “da luoghi grandi ne segue la familiarità di seculari, la dificultà di osservarci la santa povertà, fondamento della nostra Regola; si perde la quiete et poco si attende alla santa oratione, la quale è fine della nostra Religione”[110].
Bernardino Cioli da Colpetrazzo, per bocca di Francesco Ripanti da Jesi, focalizza i punti nodali della problematica che investe i cappuccini in questi anni. L’osservanza della perfetta povertà non può che partire da un desiderio profondo di seguire San Francesco e suoi compagni. Il grande numero è causa del calo di fervore, l’orazione contemplativa, ciò a cui ogni cappuccino deve tendere e che non ha altro fondamento che l’adorazione di Cristo Crocifisso, è messa in pericolo dalla cresciuta attività apostolica.
Le istanze positive che reclamavano un ritorno alla quiete della contemplazione vissuta in austerità, non cancellava totalmente l’impegno apostolico dentro la Chiesa. Se la vita contemplativa è più conforme al santo Vangelo, la vita apostolica, osserva con la povertà “li duoi precetti dell'amor di Dio et del prossimo, dando opera all'amor’ di Dio nella santa oratione et nella predicatione all'amor del prossimo”. È una difesa di quella vita mista[111] che poteva essere mantenuta nel giusto equilibrio solo vivendo in modo integrale la Regola che, ponendo la povertà come “regina et matre di tutte le virtù” (Cost. 1536, 27) “ci purga da ogni affetione terrena et ci rende atti all'orare; con l'oratione ci ordina con Dio; con la predicazione et il buon esempio ci ordina col prossimo”[112].
La crisi “maddalenita” rivelava come nell’Ordine andava crescendo il desiderio per un ritorno all’austerità primitiva che avrebbe permesso di vivere l’ideale primitivo.
Le Cronache e le Historie focalizzano in Girolamo Pratelli da Montefiore il personaggio più rappresentativo che “si sforzò quanto potè di ridur’ la Congregatione universalmente alla perfetta osservanza della Regola”[113] e che “molto amava quei sudditi et quei prelati li quali egli conosceva o riputava haver zelo della povertà”[114].
È in questo clima che su iniziativa del Vicario generale, Girolamo Pratelli da Montefiore, 1575-1581, vengono raccolte le memorie storiche per non perdere quel bagaglio di santità dei primi frati cappuccini, “acciò dalla santità e dai costumi li frati potessino conoscere come in uno specchio la pura osservanza della nostra Regola e la vera vita spirituale, quale dovremmo tenere”[115].
Le biografie scritte da Bernardino Cioli da Colpetrazzo, dovevano diventare il testo da leggersi tra i frati, sia da quelli già “inchinati alla pura e vera oservanza della Regola”, sia perché potesse aprire “le menti a molti”[116].
Ma i fattori intervenuti in questi anni quali, la fedeltà alle direttive conciliari, le nuove esigenze della formazione dei candidati o il servizio ai frati anziani e infermi, portarono i cappuccini ad abbracciare il modello di vita conventuale. Si assiste ad un vero e proprio cambio di generazione e di mentalità, con grandi sofferenze anche personali.
Il difensore di questo stato, Mattia Bellintani da Salò, nella conclusione del suo splendido capitolo “Dei tre stati della Congregatione capuccina”, traccia una risposta alla Divota Historia di Bernardino Cioli da Colpetrazzo.
Egli afferma che la crescita di frati ha portato certamente delle modificazioni, quale è il calo di “quel primo fervore et ardore dell'austerità, il quale bolliva nel cuor di quei Padri che desiderosi della riforma haveano con gran zelo cangiato l’abito et erano huomini provetti et isperimentati nelle cose regolari”, mentre i giovani venuti all’Ordine “con animo riposato”, non hanno vissuto i travagli e le tensioni patite dalla prima e dalla seconda generazione e con lo stesso animo riposato sono “entrati nell'osservanza della Regola”.
Ma questo venire dal secolo “ha causato che.... è stato necessario farli studiare, acciò nella Congregatione non mancasse la dottrina la quale quei primi Padri haveano portata”.
“Terzo ha causato che crescendo i Frati e cessando quell'estremo et ansioso zelo della povertà, la quale così come nel principio giovò per farsi il segnalato ritiramento dalla commune relassatione, così dopo sarebbe più tosto stato impedimento al ragionevole et necessario progresso della Riforma, egli è stato mestiere accomodare i conventi già troppo lontani, presso alle terre et città. Et ciò massimamente per cagion degli infermi, li quali fra tanta copia de Frati ha luogo che siano più frequenti”.
Queste cause hanno fatto sì che “la vita, i luoghi e gli habiti et tutto il resto si è ridotto ad uno stato mezano et ad un religioso corso; onde con l’osservanza sostanziale della Regola viver possono quelli ancora, li quali non hano tanto bollimento di spirito come haveano i primi fondatori, et tutta via quelli hanno quanta commodità si bramino, li quali con ardente spirito procacciano la perfettione della virtù et della evangelica, li quali ricoperti dell'ordinario vivere il quale per essere nel di fuori commune a quelli ancora li quali contenti di quel che è necessario per salvarsi tanto alto non aspirano, seguono più sicuri il santo loro istituto di conseguire la vera santità appresso al Dador celeste, il quale nell’ascoso vide”[117].
Gli ultimi venti anni del Cinquecento vedono l’Ordine dei cappuccini affrontare un nuovo passaggio adattivo, non privo di contrasti, tensioni e sofferenze personali.
Il modello conventuale andrà sviluppandosi con gradualità, così come era accaduto per il passaggio dal modello eremitico, che per semplicità possiamo mettere sotto il nome di Ludovico Tenaglia da Fossombrone, a quello carismatico, di Bernardino Tomassini da Siena e poi raccolto e filtrato da Bernardino Palli d’Asti e Francesco Ripanti da Jesi. I confini tra un modello ed un altro non sono mai netti, proprio perché investono l’uomo e la sua tensione vitale ed ideale.
[1] Nella stessa celebrazione il papa canonizzò il teatino Andrea Avellino (1521-1608), il papa domenicano Pio V (1504-1572) e la clarissa Caterina Vigri da Bologna (1413-1463).
[2] Ebbe quattro figli. Pierluigi partecipò come comandante di un plotone al sacco di Roma nel 1527.
Palazzo Farnese, stranamente, fu risparmiato dalla furia dei lanzichenecchi.
[3] Si contano negli anni del suo pontificato quasi un centinaio di vescovi residenti a Roma che mai avevano messo piede nella propria diocesi.
[4] La Battaglia di Mühlberg fu una grande battaglia combattuta il 24 aprile 1547 fra le truppe imperiali guidate da Carlo V e le truppe della Lega Smalcaldica al comando del Principe elettore di Sassonia Giovanni Federico. Gli ufficiali della Lega di Smalcalda non si accordarono sulle azioni da intraprendere sul campo di battaglia, permettendo a Carlo V di penetrare nelle loro difese. Le truppe imperiali sbaragliarono pertanto le truppe della lega protestante mentre lo stesso elettore di Sassonia venne fatto prigioniero.
[5] Così Bernardino Tomassini scriveva alla Marchesa di Pescare, Vittoria Colonna. “Dapoi che farei in Italia? Predicare sospetto et predicare Cristo sempre mascarato in zergo? E molte volte bisognò blasfemarlo per sadisfare alla suppestitione del mondo, e non basta, e ad ogni sgraziato basterebbe l’animo scrivere a Roma, pontarmi. Ritorneremo presto alle medesimi tumulti. E scrivendo manco potrei dare in luce alcuna cosa alcuna” (BERNARDINO OCHINO, Lettera a Vittoria Colonna, 22 agosto 1542, in FC II, 261).
[6] Monumenta Historica Ordinis Capucinorum (MHOC) IV, 259.
[7] MHOC I, 438.
[8] MHOC VI, 158-172. E’ Mattia Bellintani da Salò che nella sua Cronaca ci ha trasmesso il testo. Egli individua in Ludovico Tenaglia da Fossombrone il responsabile primo della redazione del testo, qualificandolo come un vero e proprio apparato legislativo: “Costituzioni che fecero in Alvacina”. La maggior parte degli studiosi cappuccini considera questo testo come una semplice dichiarazione o al più norme che tentavano un indirizzo per regolare l’inizio della riforma, escludendo che esse siano un vero e proprio apparato legislativo. Cf FC I, 166-167.
[9] Religionis Zelus, in FC I, 61-69.
[10] Nell’agosto del 1529 si aggiungerà a questo primo nucleo il gruppo dei frati calabresi guidati da Ludovico Comi da Reggio Calabria e Bernardino Molizzi da Reggio Calabria.
[11] Delle fonti francescane che i primi cappuccini avevano a disposizione essi utilizzano ciò che ha un’immediata e sicura risonanza riformistica. “pigliando per loro dottrina la speranza e gli avvertimenti del serafico padre, che scritti sono per utilità universale nei libri della nostra Religione, cioè nelle Conformità, nelle Cronache dell’Ordine, nella Legenda di san Bonaventura e quella fu scritta dai tre solennissimi compagni del serafico padre san Francesco: frate Leone, fra Angelo e frate Ruffino” (MHOC IV, 4).
[12] MHOC IV, 42.
[13] MHOC IV, 195-196.
Matteo Serafini da Bascio, quando ancora era tra gli Osservanti, fa esperienza di servizio agli appestati durante l’epidemia che scoppia a Camerino nel 1523. Insieme ai fratelli Tenaglia e a Paolo Barbieri da Chioggia, quarto venuto alla riforma, è di nuovo in mezzo agli appestati di Camerino nel 1527. E’ in questi momenti che si attirano l’ammirazione di Caterina Cibo, duchessa di Camerino.
[14] Cf. Alb., 4; Cost. 1536, 70.
Le Cronache insistono nel riferire come nei luoghi si visse in solitudine, ma contemporaneamente in fraternità (MHOC IV, 42).
[15] Cf. Cost. 1536, 25-26.
[16] MHOC IV, 194-195.
[17] Ibidem, 195: “Per la qual cosa i cappuccini molti che sapevano lavorare certi esercitij honesti, come tessere, cucire i panni, le scarpe, far sporte, canestri, et simili cose, lavoravano; et in molti luoghi ordirono i telari, si come ho visto con i proprij ochi in Roma in S. Nicola, ove erano quattro o cinque telari; et tanto si guadagnava che quasi bastava per il vitto a tutti i Frati. Il medesimo a Genova, ove tessevano panni di gran valore e stillavano ancora herbe. Talmente che in più luoghi quasi vivevano delle loro fatiche”.
MHOC III, 134: “Quando che occorreva mangiare di quelle cose che con esercizio lui [Benedetto da Subiaco] e altri frati di quel tempo guadagnavano, spesso volte mangiando, giongeva le mani e alzava gli occhi al cielo. E più volte ci fu visto lacrimare, e diceva: Ringraziato sia Dio! S’è pur adempiuto il desiderio mio che ho avuto sempre di vivere delle mie fatiche”.
[18] Nato nel 1502 ad Hasselt (Belgio), dottorato in filosofia a Lovanio, entra nel 1523 tra gli Osservanti, per passare ai cappuccini della Provincia Romana negli anni 1535-1536. Muore il 12 settembre 1537.
[19] “Fu visitato da tanti padri ultramontani che l’avevan conosciuto nella Religione tanto onorato e ora lo vedevano essersi privo di libri, come semplice fraticello, scalzo e vestito d’abito d’arbascio” (MHOC II, 281).
[20] MHOC III, 176.
[21] MHOC VI, 183.
[22] MHOC III, 176.
[23] MHOC II, 368.
[24] La In Suprema militantis alimentò le speranze di chi nell’Osservanza credeva giunto il momento della riforma all’interno dell’Ordine stesso, ma l’ottusità del Ministro Generale, Paolo Risotti, infrangeva il fervore e le speranze.
[25] MHOC III, 259. “Et all’hora appress’il mondo alzò il capo la puovera Congregatione, imperocché per la venuta di questi grand’huomini e per le loro predicazioni resero la Congregazione celeberrima a tutt’il mondo più appress’i Prelati della Chiesa.” (MHOC II, 258).
[26] E’ interessante la cronaca di suor Caterina Guarnieri da Osimo, clarissa e cronista del monastero di S. Lucia di Foligno. Essa annota, ma sotto l’anno 1532, quando i frati cappuccini sono arrivati a Foligno già nel 1530, la comparsa della riforma. “In questo tempo, ciò è nel 1532, uscì fora una setta de’ frati, pure al tempo di Clemente papa, chiamati scappucin. Dicono che sono veri frati, e che observano a lictera la regula de sancto Francesco; portano abiti di panno grosso e arapeçati e li cappucci agui e vanno scalçi e vivono a dì a dì, per modo che sonno in grande devozione delli populi, e molti delli frati observanti entravano in fra loro” (in FC II, 417).
[27] MHOC IV, 44.
[28] MHOC, IV 196.
[29] Ibidem, 197.
[30] Bernardino Cioli da Colpetrazzo ci riferisce che “tutti gli essercitij furono moderati dal Venerabile Padre Fra Francesco da Jesi” (MHOC IV, 1979), ma questi fu Vicario Generale dal 153 al 1549, quindi alcuni anni dopo l’uscita di scena sia di Ludovico Tenaglia da Fossombrone sia di Francesco Tittelmans da Hasselt.
[31] MHOC IV, 198.
[32] Ibidem, 198.
[33] Paolo SIMONCELLI, Evangelismo italiano nel Cinquecento, Roma 1979, 44-45.
[34] Delio CANTIMORI, La Riforma in Italia, in Questioni di storia moderna, a cura di E. ROTA, Milano[?j, 183.
[35] P. SIMONCELLI, Evangelismo italiano nel Cinquecento, Roma 1979, 53.
[36] Si dice che passando per Spoleto e vedendo l’eremo dei cappuccini abbia esclamato: “fra breve non vi saranno più ne cappuccini ne conventi di cappuccini”.
[37] Francesco Ripanti era nato nel 1469 a Jesi e con buon profitto aveva studiato Diritto Canonico e Civile a Perugia, senza aver raggiunto il Dottorato. I suoi concittadini, alla morte del Vescovo, lo vorrebbero come successore, ma il Ripanti lascia tutto ed entra tra gli Osservanti.
I superiori gli fanno continuare gli studi in teologia “ne quali fé tal profitto ch’egli un dottissimo theologo n’uscì” (MHOC VI, 119). Espertissimo del pensiero di Scoto (MHOC III, 74). Ottenuto il permesso dalla Sede Apostolica inizia a predicare nelle città delle Marche, “ma infatti non vedendosi a fare que frutto che sperato havea, parvegli bene di ritornarsene alla sua solita contemplatione et vita solitaria, alla quale da dio si vedeva chiamato” (MHOC VI, 120). Passa in questa vita quattordici anni sperando in una riforma dell’Osservanza, riforma che però stenta ad essere recepita ed attuata. E così “venutaglia agli orecchi quella de’ Capuccini...vennegli la gran voglia per desiderio ardente della perfetione di entrarvi” (MHOC VI, 121), si reca a Roma da Ludovico da Fossombrone, ma questi lo informa che il suo desiderio è inattuabile perché il Breve di Clemente VII, Cum sicut accepimus, proibiva il passaggio degli Osservanti ai Cappuccini. Vestirà definitivamente l’abito cappuccino nel 1534 a Camerino, dopo che, ottenute le Bolle per suscitare la riforma nell’Osservanza, era stato messo in prigione. Nel Capitolo generale del 1535, un anno dopo la sua entrata nella “riforma” è eletto Definitore generale, riconfermato nel 1538 e 1541. Dopo la fuga dell’Ochino viene nominato Commissario generale e quindi nel 1543 è eletto dal Capitolo generale, Vicario generale dell’Ordine.
[38] MHOC VI, 128.
[39] “...visitò la congregatione et attese da una parte ad inquirere con diligenza se vi era rimasta alcuna infettione”, (Ibidem VI, 114).
[40] MHOC IV, 127-132.
[41] MHOC VII, 278-279.
[42] NICOLINI, Ideali e passioni dell’Italia religiosa del Cinquecento, Bologna 1962.
[43] Costanzo CARGNONI, Fonti, tendenze e sviluppi della letteratura spirituale cappuccina primitiva, in CF 48 (1978) 340.
[44] MHOC VI, 122.
[45] Ibidem, 128.
Mattia Bellintani da Salò ci riferisce che, ottenuto il permesso dalla Santa Sede, inizia la sua predicazione nelle città delle Marche, “ma infatti non vedendosi a fare quel frutto che sperato havea, parvegli bene di ritornarsene alla sua solita contemplatione el vita solitaria, alla quale da dio si vedeva chiamato” (Ibidem, 120).
[46] Ibidem, 114.
Il suo metodo, Circolo del divino amore, era stato pubblicato a Milano nel 1539 in aggiunta ai 52 capitoli dell’opera di Bartolomeo CORDONI DA CITTÁ DI CASTELLO, un frate osservante morto quattro anni prima, De unione anime cum superminenti lumine, già pubblicato a Perugia nel 1538. La pubblicazione postuma e 1’aggiunta sono opera del frate cappuccino Girolamo DA MOLFETTA, amico e seguace dell’Ochino. L’opera riceve come titolo quello di Dialogo della unione spirituale de Dio con l’anima. Per le vicende di questa opera e la condanna da parte dell’Inquisizione si veda: Costanzo CARGNONI, Fonti, tendenze e sviluppi dello letteratura spirituale cappuccino primitiva, in CF 48 (1978) 344-379.
[47] MHOC IV, 24.
Se le Costituzioni del 1536 ordinano che nelle sagrestie dei frati vi siano “doi piccoli calici, uno di stagno e l’altro con la sola coppa de argento” (Cost. 1536, 140), le Costituzioni del 1552 ordinano che ci siano due calici con “la coppa di argento” (Cost. 1536, 140,4).
[48] Entrato tra gli Osservanti e più volte Ministro della Provincia di Roma, passa ai Cappuccini nel 1533, diventando il successore di Ludovico Tenaglia da Fossombrone nel tumultuoso Capitolo generale del 1535. A causa della malattia rinuncerà all’incarico nel 1538 sostituito da BernardinoTomassini da Siena, l’Ochino. Dopo l’apostasia di quest’ultimo ed il triennio di Francesco Ripanti da Jesi, verrà nuovamente eletto Vicario generale, nei Capitoli del 1546 e 1549. Partecipò al primo periodo del Concilio di Trento. Morirà a Roma nel 1557.
[49] “Questo buon padre fu quello che diede la forma religiosa alla Congregazione degli Cappuccini che infimo all’hora non havea potuta havere per non essere i Frati molti, per venire tutta via di nuovi, per attendersi continuamente al fabricar conventi, per essere occupati a resistere a gli avversarij et perché non erano visitati dal Generale... “(MHOC VI, 22).
[50] BERNARDINUS AB ASTI, Memoriale, in EDUARDUS ALENCONIENSIS, Tribulationes Ordinis fratrum minorum capuccinorum primis annis pontifìcatus Pauli III (1534-1541), Romae 1914.
[51] “...attese a piantare bene la santa povertà nella Congregazione, nel che però poco havea da restringere ma si bene molto da ridurre a termini della discretione, accioché la cosa potesse durare con salute e sanità dei frati”. (MHOC VI, 24-25).
[52] Ibidem,VI, 26.
[53] MHOC IV, 9.
[54] BERNARDINO PALLI D’ASTI, Rallegratevi sempre, Castrogiovanni 6 giugno 1548, in Litterae circulares supenorum generalium Ordinis fratrum minorum capuccinorum (1548-1803), in lucem editae a P. Melchiorre a Pobladura, (MHOC VIII), Romae 1960, 4-6.
[55] La lettera Rallegratevi sempre è stata nuovamente edita nella recente pubblicazione curata da Costanzo CARGNONI, FC II, 831-833, ma senza l’apparato critico, presente invece nella pubblicazione curata da P. MELCHIORRE DA POBLADURA, (MHOC VIII), 4-6. Varianti che spesso sono importanti per comprendere l’humus di vita dei primi cappuccini.
[56] MHOC VI, 32-34.
[57] Ibidem, 19.
[58] Ibidem, 33
[59] Ci sono trasmesse delle scenette di inaspettata semplicità, come quella che ci racconta Bernardino Cioli da Colpetrazzo riguardante fra Egidio da Orvieto “laico di gran valore”, ma che temendo che fra i suoi ascoltatori potesse esserci qualche letterato, metteva in atto un piccolo trucco chiedendo penna e calamaio e, avutane risposta negativa, “qui non ci è né carta né calamaio; non ci è nessuna che sappia niente”, iniziava la sua predicazione (Cf. MHOC IV, 44).
[60] MHOC VII, 357.
[61] Ibidem, 361.
[62] MHOC III, 188.
[63] MHOC IV, 198.
[64] Ibidem, 279.
[65] BERNARDINO PALLI D’ASTI. Rallegratevi sempre, in MHOC VIII, 6.
[66] MHOC VI, 32.
[67] Ibidem 34.
[68] MHOC IV, 16.
[69] MHOC VI, 279.
[70] MHOC VI, 283.
L’espressione è ricorrente nella Historia di Mattia Bellintani da Salò qualificando ed individuando un gruppo ben definito e contrapposto ai giovani.
Un segno dell’esistenza di una divisione in seno all’Ordine è il racconto della fondazione della Provincia di Basilicata. “Circa quei tempi ancora si separarono dalla Provincia della Puglia cinque luoghi posti nella montagna, sotto pretesto che quelli del piano non potessero sopportare il freddo dei monti, né i montagnani il caldo della Puglia. I cinque luoghi andarono pigliandone degli altri vicino a loro, che appartenevano secondo la divisione di S. Bonaventura alla Provincia di Napoli, la quale per esserli luoghi lontani, et perché i vecchi che la governavano non curavano di allargarsi in pigliar luoghi, non vietò a quei Frati il pigliare i luoghi suoi infinché tanto si avvicinarono, che ancora il luogo della Cava si pigliarono. Et venne quella Provincia chiamata Basilicata” (Ibidem, 283).
[71] Ibidem, 279.
[72] MHOC VI, 296.
[73] Ibidem, 293-294.
[74] Ibidem, 294.
[75] Ibidem, 297.
Il nostro aveva vissuto in prima persona, tra il 1565 ed il 1568, lo scontro tra frati vecchi e frati giovani che aveva interessato la Provincia di Milano, in quanto definitore della stessa, fu coinvolto nella deposizione del Ministro Provinciale il padre Apollonio Porcellagra da Brescia. Motivo del contendere erano le fabbriche, la costruzione dei molti e nuovi conventi (cf. SALVATORE RASARI DA RIVOLTA D’ADDA, Fontatione de’ conventi della provincia di Milano de’ frati minori del padre san Francesco detti cappuccini. Edito da METODIO DA NEMBRO, in Salvatore da Rivolta e la sua cronaca, Milano 1973)
[76] MHOC VI, 281.
[77] MHOC III, 77.
[78] Possiamo seguire l’evoluzione numerica in quanto ad ogni Capitolo generale veniva data la relazione sul numero delle case e dei religiosi. Cf. Collectio authentica, in AOC 5 (1889), 10-21; 55-57; 72-82; 103-108; 133-141.
[79] Dal 1564 l’Ordine ha un proprio Cardinale protettore distinto dal quello dell’Osservanza. Diversi sono poi i cappuccini che partecipano all’ultima sessione del Concilio di Trento: Bernardino Palli d’Asti, Evangelista Ferratine da Canobbio, Girolamo Finucci da Pistoia, Francesco Arconti da Milano, Angelo da Asti, Girolamo Pratelli da Montefiore e Tommaso da Città di Castello. Quest’ultimo ottenne che i cappuccini fossero esonerati dal divieto di possedere dei beni immobili.
[80] La prima Relazione, molto breve, scritta nel 1565, era stata preparata per andare incontro al desiderio di Cosimo I de’ Medici che voleva conoscere chi erano i cappuccini. La seconda Relazione invece dava seguito alla richiesta del Cardinale Protettore, Giulio Antonio Sartori, scritta nel 1569. La terza Relazione, 1580, era la risposta alle polemiche suscitate da Giuseppe Zarlino che aveva attribuito a torto l’aureola di iniziatore della “riforma cappuccina” a Paolo Barbieri da Chioggia anziché a Matteo Serafini da Bascio.
[81] Per una biografia esaustiva: Callisto URBANELLI, Storia dei cappuccini delle Marche, II-III, Ancona, 1978-1984.
[82] Il manoscritto è conservato nell’Archivio generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Roma AB2.
[83] GIROLAMO DA MONTEFIORE, Alli divoti lettori, in FC II, 929.
[84] MHOC II, 11.
La lettera datata 21 marzo 1580 e indirizzata a Bernardino Cioli da Colpetrazzo per ringraziarlo del lavoro svolto è pubblicata nella Introduzione della Semplice et Divota Historia.
[85] GIROLAMO DA MONTEFIORE, Alli divoti lettori, in FC II, 929.
[86] METODIO DA NEMBRO, Salvatore da Rivolta e la sua Cronaca, Milano 1973, 47-48
[87] MHOC VI, 310-311.
[88] Ibidem, 352.
[89] Ibidem, 352.
[90] MHOC II, 3
[91] “Ma io che mi trovai in quel tempo nella povera Congregatione, giuditiosamente ripensando, dico ch’il più glorioso stato sia stato mai nella nostra Congregatione fu dal ‘28 insino nel ‘33 perché fu più conforme al principio della Religione et al tempo del Padre S. Francesco. Non niego però ch’il secondo stato, insino al ’43, non fusse più glorioso appresso il mondo e che non ci fussero maggior numero de’ frati e più dotti e gran predicatori; ma, perché la religione del serafico Francesco è fondata in umiltà, povertà e desprezzo di se stesso e nella santa contemplazione, mai fu più conforme a tutte queste cose che dicono perfezzione, quanto fu nel primo stato, dove veramente, con ogni grado di perfezione, se renuovò il primo stato della religione e fu reso al mondo l’abbito, la vita, l’umiltà, il disprezzo del mondo e la vera contemplazione che tenne il padre san Francesco con i suoi compagni”. MHOC II, 259.
[92] MHOC VI, 414-420. È forse questa la caratteristica, ardita per la verità, della sua storiografia.
[93] Ibidem, 273-274.
[94] Ibidem, 277.
[95] PAOLO II, Ad Dominici gregis curam, 2 giungo 1536.
[96] MHOC VI, 279.
[97] Ibidem, 279 ss.
[98] Ibidem, 281.
[99] “L’anno dunque 1582 fu celebrato il Capitolo Provinciale nel luogo di Milano, nel quale fu confirmato il P. Mattia (da Salò ) suddetto, il quale per le sue stravaganze nel suo governo fu chiamato a Roma” (METODIO DA NEMBRO, Salvatore da Rivolta e la sua Cronaca, Milano 1973,77).
Il fatto contingente che porta alla sospensione di Mattia Bellintani da Salò dal suo ufficio è l’uso dei latticini nei giorni di digiuno. La corrente avversaria era per un’osservanza rigida ed austera. Mattia all’opposto considerando la fatica dei suoi frati, impegnati in faticosi campi di apostolato di frontiera, soprattutto nella Valtellina territorio di confine con i protestanti Grigioni, cerca di mitigare la rigidità della mensa. Denunciato da parte di un lettore dello studio di Milano, che tanto fece valere le sue argomentazioni, da venire chiamato a Roma e sospeso dal suo incarico di Provinciale (Cf. VALDEMIRO [BONARI] DA BERGAMO, I conventi cappuccini della provincia milanese, I, Crema 1898, 176-178).
[100] Espressione ricorrente nella Historia di Mattia Bellintani da Salò che qualifica ed individua un gruppo ben definito e contrapposto ai giovani. Un segno dell’esistenza di una divisione in seno all’Ordine è il racconto della fondazione della Provincia di Basilicata. “Circa quei tempi ancora si separarono dalla Provincia della Puglia cinque luoghi posti nella montagna, sotto pretesto che quelli del piano non potessero sopportare il freddo dei monti, né i montagnani il caldo della Puglia: I cinque luoghi andarono pigliandone degli altri vicino a loro, che appartenevano secondo la divisione di S. Bonaventura alla Provincia di Napoli, la quale per esserli quei luoghi lontani, et perché i vecchi che la governavano non curavano di allargarsi in pigliar luoghi, non vietò a quei Frati il pigliare i luoghi suoi infinchè tanto si avvicinarono che ancora il luogo della Cava si pigliarono. Et venne quella Provincia chiamata Basilicata” (Ibidem, 283).
[101] MHOC VI, 296.
[102] Ibidem, 293-294.
[103] Ibidem, 294.
[104] MHOC VI, 297.
[105] Ibidem, 281.
[106] MHOC III, 77.
[107] Cf. MHOC VI, 293.
[108] Il 6 maggio 1574 con la Bolla Ex Nostri Pastoralis Officii, Gregorio XIII revocava il Breve di Paolo III, Dudum siquidem del 5 gennaio 1537 e permetteva all’Ordine di stabilire case, custodie, luoghi e Province in Francia, secondo le consuetudini dell’Ordine. In questo periodo la Valtellina diventa punto di concentrazione nella lotta contro gli eretici dei Grigioni. Una richiesta di missionari da inviare ai confini settentrionali dell’Italia viene presentata dall’Arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, all’allora Vicario generale, Mario Fabiani da Mercato Saraceno e discussa nel Capitolo del 12 maggio 1570 (Cf. Collecrio authentica 5 (1889) 819). La figura di Giuseppe da Leonessa (1556-1612) missionario nelle terre d’Oriente nel 1587 non è la sola dell’impegno dei cappuccini (Cf. FC I, 122-129; 1649-1653). Già dal 1571 ben trenta cappuccini sono inviati, alla diretta dipendenza del papa, per essere imbarcati come cappellani sulle navi che nel Mediterraneo contrastano i turchi (Cf. Collectio authentica, 5 -1889- 81).
[109] La medesima opinione, Bernardino Cioli da Colpetrazzo, la esprime nella Ratio vivendi fratrum (MHOC IV, 167) e nella biografia di Giustino da Panicale (MHOC III, 433-434).
[110] MHOC III, 79.
[111] Una nota curiosa che ci proviene da un testimone esterno è la notizia di quella mediazione che è stata effettuata durante il primo passaggio di adattamento negli anni 1532-1534. Suor Caterina Guamieri da Osimo (vedi anche nota 173) così scrive nella sua cronaca: “Li predicti scapuccini hanno deminuitol’ofizio devino: non dicono se non tre salmi e tre leczioni. Dicono el fanno per vaccare meglio all’orazione; niente de macho (sìc!) el fine farà tucto” (FC II, 418).
[112] MHOC III, 80.
[113] MHOC IV, 138.
[114] MHOC VI, 349.
[115] GIROLAMO DA MONTEFIORE, Alli divoti lettori, in FC II, 929.
[116] MHOC II, 11.
[117] MHOC VI, 280-281.
